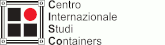
|
| CENTRO ITALIANO STUDI CONTAINERS | ANNO XX - Numero 7-8/2002 - LUGLIO/AGOSTO 2002 |
Studi e ricerche
Le economie di scala delle portacontainers: le dimensioni non
sono tutto
Potrebbe risultare una sorpresa per i dirigenti di alcuni vettori
marittimi, ma l'acquisto di portacontainers di dimensioni da 6.000
a 8.000 TEU non risulta necessariamente una strategia che rende
profitti. Questa è stata nella sostanza la premessa esposta
dal direttore generale della Clarkson Research, Martin Stopford,
alla conferenza annuale sullo shipping di Containerisation
International svoltasi a Londra nello scorso mese di aprile.
Pertanto, i vettori marittimi avrebbero sbagliato tutto?
Stopford ha suggerito che alcune linee di navigazione potrebbero
essere l'oggetto dello studio realizzato nel 1999 "Malacca-Max:
la portacontainer suprema" in cui si afferma: "Il progetto
Malacca-Max (navi da 18.000 TEU) presenta un livello di costo
minimo complessivo pari al 16% circa in più rispetto alle
attuali navi più grandi da 8.000 TEU. In un mondo di concorrenza
da tagliagole quale è quello attuale, il 16% potrebbe fare
una differenza decisiva". Stopford riferisce che quando i
traffici erano in un ciclo positivo, nel 1999, molti vettori marittimi
avevano tratto vantaggio dalle tariffe di costruzione delle navi
più a buon mercato in Asia ed avevano ordinato navi dalla
capacità di 6.000 TEU che sono poi state immesse nei traffici
est-ovest negli ultimi mesi.
La tendenza verso l'impiego di navi più grandi figura
in modo preponderante nelle strategie di molti vettori marittimi,
dal momento che essi hanno cercato di conseguire economie di scala.
Tuttavia, vi sono molte componenti che questa strategia comporta,
alcune delle quali possono essere negative. Secondo Stopford,
il costo medio di una nave da 6.000 TEU è di circa 64 milioni
di dollari rispetto ai 12 milioni di dollari di una nave da 735
TEU. Tuttavia, mentre il costo medio in proporzione per 1.000
TEU cala dai 18 milioni di dollari per una nave da 725 TEU a 12
milioni di dollari per una nave da 1.700 TEU, vi è una
piccola ulteriore riduzione se si va oltre, ed una nave da 6.200
TEU costa ancora 10,3 milioni di dollari per 1.000 TEU. Perciò,
il risparmio di capitale per 1.000 TEU in ordine alla costruzione
di una nave da 6.000 TEU, rispetto a quattro navi da 1.700 TEU,
è relativamente piccolo.
Allo stesso modo, Stopford argomenta che i costi operativi, che
comprendono l'equipaggio, l'assicurazione ed i costi di manutenzione,
offrono poche opportunità per economie di scala. Vi è
poca differenza nei livelli di dotazione del personale fra portacontainers
medie e grandi, dato che l'equipaggio medio di una moderna portacontainers
consiste di sole 14 persone. Tuttavia, l'assicurazione dello scafo
aumenta notevolmente con le dimensioni della nave. Alcuni vettori
marittimi sono stati anche penalizzati dopo l'11 settembre 2001,
dal momento che gli assicuratori hanno calcolato premi aggiuntivi
per i rischi di guerra, basati sul valore dello scafo e dei motori
delle portacontainers. Né pare che i costi di bunkeraggio
possano offrire molto risparmio potenziale sui costi ai vettori
marittimi.
L'essenza dello studio di Stopford è che la strategia
dei vettori marittimi dovrebbe concentrarsi sull'incremento della
capacità di navi di dimensioni medie. Stopford rivela che
incrementando le dimensioni delle navi da 1.000 a 2.000 TEU, si
è risparmiato il 20% nel costo di trasporto unitario; da
2.000 a 4.000 TEU, il risparmio è stato del 7%, mentre
- ed è interessante notarlo - dai 4.000 ai 6.000 TEU si
è risparmiato solo il 4%. Poi concede: "Certo, ci
sono economie di scala, ma poiché esse diminuiscono con
le dimensioni, i maggiori benefici verranno conseguiti mediante
l'aumento delle dimensioni dei carichi nei minori segmenti della
flotta containerizzata, e non con la costruzione di super-navi".
Ciò detto, Stopford procede nell'affermare che le piccole
economie di scala associate alle navi post-panamax possono facilmente
essere dissipate attraverso i costi aggiuntivi derivanti da altre
cause. A causa delle limitazioni di pescaggio, c'è solo
un limitato numero di porti in grado di movimentarle, il che comporta
altri costi di raccordo e di trasbordo. In molti casi, tali costi
oltrepassano di gran lunga i risparmi sui costi delle navi.
In costi aggiuntivi di raccordo e trasbordo si può altresì
incorrere attraverso la necessità di far tornare indietro
le navi il più alla svelta possibile a ciascun capolinea
di traffico allo scopo di minimizzare le dimensioni della flotta.
Se si richiede una ulteriore nave per coprire più porti,
l'incremento di costo per una nave grande è molto maggiore
rispetto a quello di una nave più piccola. Poi, c'è
la ridotta flessibilità delle navi più grandi. Laddove
le navi più piccole possono essere smistate più
facilmente tra direttrici di traffico al fine di bilanciare l'offerta
con la domanda, le navi post-panamax normalmente possono essere
solamente ritirate, com'è stato recentemente sperimentato
dalla P&O Nedlloyd con la PONL Shackleton.
Esistono ulteriori ramificazioni relative alla catena dell'offerta
derivanti dall'impiego di grosse navi, tra cui la capacità
dei porti e dei singoli terminals di movimentare navi di mega-dimensioni.
Ciò potrebbe comportare scavi per aumentare la profondità
delle acque (come a Shanghai) e l'acquisizione di speciali gru
da banchina. C'è altresì da tenere in considerazione
l'impatto che tali navi hanno sulle connessioni intermodali.
Nel corso delle stessa conferenza, Jim Brennan, socio della ditta
statunitense di consulenza Norbridge, ha avvertito: "Un allacciamento
transpacifico di mega-navi (con capacità superiore ai 6.000
TEU) richiede una quota di mercato del 40% del traffico Cina/Costa
Occidentale USA per poter conseguire economie di scala appropriate".
Ciò equivale ad almeno il 90% di utilizzazione della nave.
Inoltre, Brennan ha sottolineato che i terminals hanno bisogno
di lavorare le navi in sole 22 ore e che ciò sta al di
sotto del numero di gru disponibili; non si tratta, quindi, di
un mero discorso in ordine alla produttività di ciascuna
singola nave.
I vettori marittimi hanno tratto vantaggio dalla progressiva
containerizzazione dei traffici e dei carichi, e l'ingresso della
Cina alla WTO contribuirà anch'esso all'ulteriore futura
crescita. Tuttavia, Stopford ritiene che il completamento della
matrice dei traffici nei prossimi 20 anni avverrà per lo
più al di fuori del principale asse est-ovest e si verificherà
in Sudamerica, in Europa Orientale ed anche in Cina. Questo potrebbe
concentrare la crescita sulle navi di medie dimensioni ed è
questa l'area in cui i vettori marittimi beneficeranno delle maggiori
economie di scala.
Il suggerimento di Stopford ai partecipanti alla conferenza è
stato molto semplice: "Quando si pensa in grande, pensate
in piccolo".
(da: Containerisation International, giugno 2002)
|